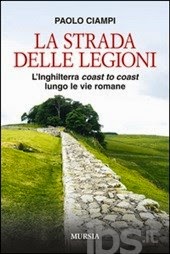Il giornalismo è l'arte di arrivare troppo tardi il più in fretta possibile. Io non l'imparerò mai.
Così scrive, come a giustificarsi, Stig Dagerman. E in realtà non ne avrebbe bisogno: nella raccolta di articoli pubblicati da Iperborea con il titolo Autunno tedesco dimostra di essere nel tempo e nel luogo giusto per raccontare un passaggio della storia che mette a nudo questioni di sempre e di tutti.
Germania, anno zero dopo la sconfitta della follia criminale di Hitler. Il paese è in macerie, il popolo alla fame. E' il momento della resa dei conti e di un presente sospeso tra gli orrori che si sono consumati e il groviglio degli alibi, degli opportunismi, dei rimpalli di responsabilità.
Abbondano i giornalisti inviati dal resto del mondo per raccontare la Germania vinta e distrutta. Ma la voce di Dagerman - un giovane inviato svedese con simpatie anarchiche e allergia per i luoghi comuni - si stacca da quella di ogni altro.
Non generalizza, non astrae, non guarda solo dove vuole guardare. Si muove tra le macerie di Amburgo, Berlino, Colonia. Sale su treni stipati di senzatetto, scende in cantine popolate di disperati, prende nota di genitori che vedono i figli morire di stenti, di ragazzi che rubano patate, di ragazze che si accompagnano ai soldati vincitori.
E' consapevole che la fame è una pessima maestra di democrazia. E' altrettanto consapevole dell'ipocrisia con cui si sta portando avanti il processo di denazificazione, lasciando a galla i peggiori per rifarsi sui più piccoli. Allo stesso modo, del resto, la guerra ha tolto di più a chi aveva meno, perché si bombardano le case, non i conti in banca.
Sosteneva Alain Finkielkraut:
Non cè bisogno della letteratura per imparare a leggere. C'è bisogno della letteratura per sottrarre il mondo reale alle letture sommarie.
Questo ci insegna Stig Dagerman, giornalista malgrado se stesso, soprattutto uomo che prima di tutto si è assunto la responsabilità dello sguardo, senza prescindere dal cuore. In questo simile a un altro grande del giornalismo che guarda al mondo e che al mondo si mescola. Quel Ryszard Kapuscinski che mi ha insegnato che il bravo reporter deve essere prima di tutto una brava persona.
Ecco, è questo che ho trovato, nelle terribili storie della Germania del 1946.
Così scrive, come a giustificarsi, Stig Dagerman. E in realtà non ne avrebbe bisogno: nella raccolta di articoli pubblicati da Iperborea con il titolo Autunno tedesco dimostra di essere nel tempo e nel luogo giusto per raccontare un passaggio della storia che mette a nudo questioni di sempre e di tutti.
Germania, anno zero dopo la sconfitta della follia criminale di Hitler. Il paese è in macerie, il popolo alla fame. E' il momento della resa dei conti e di un presente sospeso tra gli orrori che si sono consumati e il groviglio degli alibi, degli opportunismi, dei rimpalli di responsabilità.
Abbondano i giornalisti inviati dal resto del mondo per raccontare la Germania vinta e distrutta. Ma la voce di Dagerman - un giovane inviato svedese con simpatie anarchiche e allergia per i luoghi comuni - si stacca da quella di ogni altro.
Non generalizza, non astrae, non guarda solo dove vuole guardare. Si muove tra le macerie di Amburgo, Berlino, Colonia. Sale su treni stipati di senzatetto, scende in cantine popolate di disperati, prende nota di genitori che vedono i figli morire di stenti, di ragazzi che rubano patate, di ragazze che si accompagnano ai soldati vincitori.
E' consapevole che la fame è una pessima maestra di democrazia. E' altrettanto consapevole dell'ipocrisia con cui si sta portando avanti il processo di denazificazione, lasciando a galla i peggiori per rifarsi sui più piccoli. Allo stesso modo, del resto, la guerra ha tolto di più a chi aveva meno, perché si bombardano le case, non i conti in banca.
Sosteneva Alain Finkielkraut:
Non cè bisogno della letteratura per imparare a leggere. C'è bisogno della letteratura per sottrarre il mondo reale alle letture sommarie.
Questo ci insegna Stig Dagerman, giornalista malgrado se stesso, soprattutto uomo che prima di tutto si è assunto la responsabilità dello sguardo, senza prescindere dal cuore. In questo simile a un altro grande del giornalismo che guarda al mondo e che al mondo si mescola. Quel Ryszard Kapuscinski che mi ha insegnato che il bravo reporter deve essere prima di tutto una brava persona.
Ecco, è questo che ho trovato, nelle terribili storie della Germania del 1946.